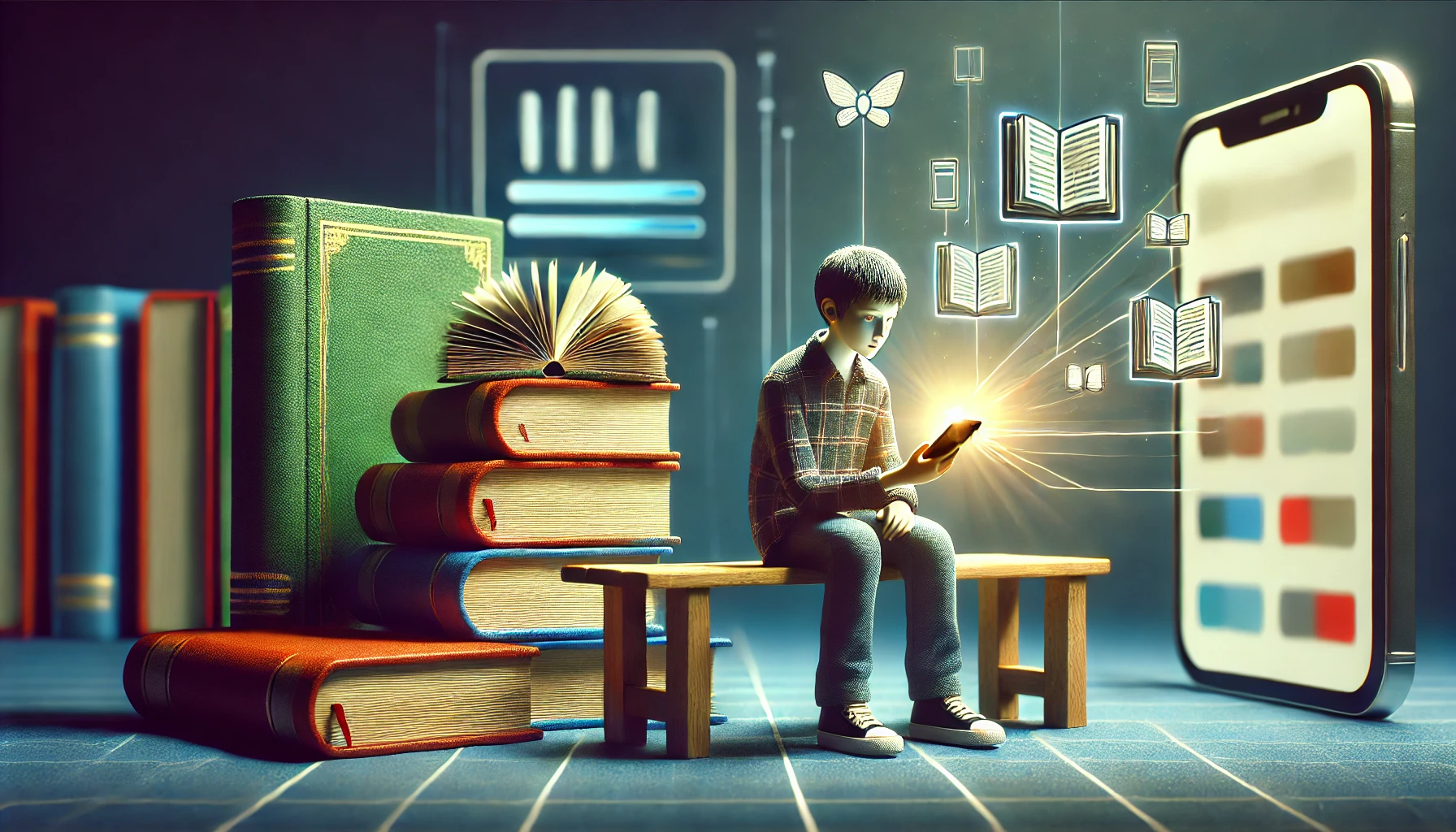I dati statistici più recenti indicano una flessione significativa dell’abitudine alla lettura tra le nuove generazioni, in particolare per quanto riguarda libri, quotidiani e saggistica. Secondo il rapporto ISTAT “Produzione e lettura di libri in Italia” (2023), solo il 39,3% della popolazione tra i 15 e i 24 anni ha letto almeno un libro nell’ultimo anno, una percentuale in calo rispetto agli anni precedenti. A questa cifra si aggiunge un altro dato allarmante: il 58% dei giovani dichiara di non considerare la lettura tra le attività di svago principali.
Tuttavia, limitarsi a constatare questa tendenza senza indagarne le cause strutturali e culturali rischia di alimentare stereotipi e generalizzazioni. Occorre invece analizzare in profondità i fattori che hanno modificato il rapporto tra i giovani e il testo scritto. Una lettura sociologica e mediatica del fenomeno permette di comprendere che non si tratta semplicemente di una perdita di interesse, bensì di una riconfigurazione del modo in cui la conoscenza, l’informazione e la narrazione vengono oggi esperite e condivise.
Com’è cambiato il contesto socioculturale
In passato, la lettura era una pratica culturalmente condivisa, inserita in rituali sociali collettivi: lo scambio di libri, la discussione tra pari, la frequentazione di spazi pubblici come biblioteche e librerie contribuivano a costruire un ecosistema favorevole alla lettura. La cultura libresca godeva di un prestigio simbolico che oggi appare ridimensionato. Oggi, tale sistema si è trasformato in modo radicale.
La diffusione di contenuti digitali personalizzati, alimentati da algoritmi che selezionano in base a interessi pregressi, ha portato a una fruizione solitaria e frammentata dell’informazione e dell’intrattenimento. La dimensione sociale della lettura si è progressivamente dissolta, soppiantata da una modalità di consumo rapido, individualizzato, spesso privo di riferimenti contestuali. Il libro, come oggetto culturale, ha perso centralità nella quotidianità dei giovani, spesso soppiantato da forme visive e audiovisive di intrattenimento.
L’effetto del digitale sull’attenzione e sul tempo cognitivo
A questo si aggiunge la questione dell’attenzione: il paradigma della “distrazione permanente”, tipico delle piattaforme digitali, ha modificato le modalità cognitive con cui si accede ai contenuti. La ridotta capacità di concentrazione non è sintomo di disinteresse, ma piuttosto effetto di un cambiamento sistemico nel modo in cui si struttura il tempo cognitivo. La lettura richiede uno sforzo prolungato, una capacità di astrazione e continuità che mal si concilia con la logica dell’interruzione costante delle notifiche, della navigazione multitasking e dell’iperstimolazione sensoriale.
Va comunque riconosciuto che i giovani leggono, anche se in forme alternative. Chat, thread, fan fiction, articoli online e sottotitoli rappresentano modalità ibride di fruizione del testo scritto. Tali pratiche, spesso considerate marginali o “di serie B”, costituiscono in realtà un punto d’ingresso prezioso per l’accesso a forme più articolate di letteratura. La cultura digitale ha introdotto nuove modalità di narrazione non-lineare e partecipativa che meritano attenzione e valorizzazione.
Il rifiuto di queste forme da parte delle generazioni adulte rischia di creare una frattura culturale e comunicativa. La svalutazione di ciò che i giovani leggono alimenta un senso di alienazione rispetto alla cultura ufficiale. Al contrario, un approccio dialogico e inclusivo permetterebbe di costruire continuità tra le pratiche di lettura quotidiane e quelle ritenute “alte”, favorendo un avvicinamento progressivo e autentico ai testi più complessi.
Tuttavia, è cruciale non cadere in un determinismo tecnologico semplicistico. I giovani dimostrano attenzione prolungata quando si confrontano con contenuti che li interpellano direttamente, anche se in formati diversi da quelli tradizionali. Serie TV, podcast narrativi, videogiochi dalla forte componente testuale: tutti questi strumenti dimostrano che la narrazione lunga e complessa non è affatto estinta, ma si esprime oggi attraverso canali alternativi.
E la scuola?
Il ruolo delle istituzioni educative in questo processo è centrale. Troppo spesso la scuola propone la lettura come attività prescrittiva e disincarnata, legata a programmi fissi e a testi canonici non contestualizzati. In questo modo, il libro diventa uno strumento valutativo anziché una porta d’accesso a esperienze di senso. L’atto del leggere viene spesso associato a obblighi scolastici e a forme di apprendimento impositive, svuotando l’esperienza del suo potenziale estetico ed emotivo.
Una didattica della lettura più flessibile e partecipativa potrebbe restituire centralità al piacere del testo, valorizzando il vissuto individuale degli studenti. L’inserimento di autori contemporanei, la valorizzazione della letteratura giovanile, il confronto con generi narrativi nuovi (graphic novel, letteratura distopica, narrativa transmediale) possono rappresentare modalità efficaci per reintrodurre la lettura come pratica rilevante nel vissuto quotidiano degli studenti.
Restituire alla lettura il suo valore simbolico ed esistenziale
Infine, manca nel discorso pubblico una narrazione forte e coerente del valore trasformativo della lettura. Leggere non significa soltanto acquisire informazioni, ma costruire identità, sviluppare empatia, elaborare emozioni. Le storie modellano il nostro immaginario, ci offrono prospettive alternative, ci aiutano a nominare ciò che sentiamo e a capire ciò che viviamo.
Tuttavia, quando la lettura viene presentata esclusivamente come strumento formativo o come dovere culturale, viene svuotata della sua dimensione esistenziale. È necessario ripensare il modo in cui parliamo di libri: non solo come patrimonio da custodire, ma come esperienza vitale e attuale. Celebrare la lettura in quanto esperienza estetica e personale può restituirle quell’aura di significato e desiderabilità che sembra oggi appannata.
In definitiva, il calo della lettura tra i giovani non va letto come segnale di decadenza culturale, ma come effetto di una trasformazione epocale dei linguaggi, dei media e delle abitudini cognitive. La lettura non è scomparsa: ha mutato forma, canali, supporti, rituali. Per invertire la tendenza, è urgente smettere di formulare giudizi semplicistici e iniziare a costruire un nuovo immaginario culturale in cui la lettura possa tornare ad avere senso, funzione e desiderabilità.
Questo implica il coinvolgimento sinergico di scuola, famiglia, media, istituzioni culturali e nuove tecnologie. Occorre promuovere politiche educative e culturali che favoriscano l’accesso ai libri, ma anche alla narrazione in senso lato. Serve ripensare gli spazi e i tempi della lettura, recuperando il valore della lentezza, della profondità, dell’intimità che solo un testo scritto sa offrire.
Il cambiamento passa anche da gesti minimi ma concreti: consigliare un libro con passione, creare spazi di confronto, valorizzare nuove forme di narrazione. Forse, è proprio da qui che occorre ripartire. Perché leggere, oggi, è ancora un atto radicale di attenzione, di cura e di resistenza.