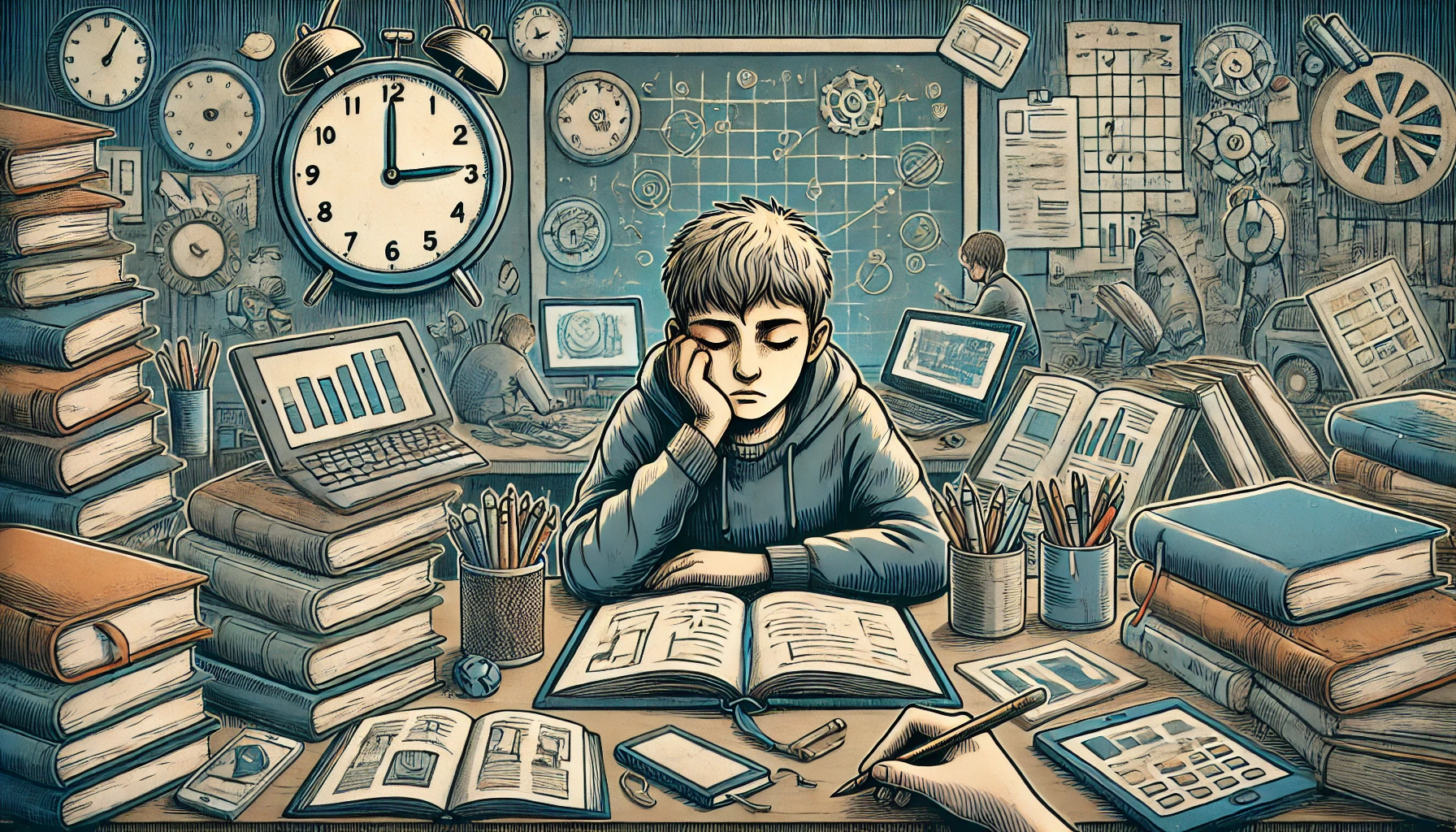Un tempo imparare era un atto di scoperta. Un’avventura intellettuale. Un viaggio carico di domande, con pochi punti fermi e molte deviazioni. Oggi, invece, è diventato un rituale meccanico. Si studia per dovere, non per desiderio. Si impara per rispondere a un test, non per comprendere il mondo. La scuola e l’università hanno ridotto la conoscenza a una serie di tappe da superare, a un percorso lineare e privo di imprevisti. Il risultato? Studenti stanchi, demotivati, annoiati.
La curiosità non muore da sola. Viene soffocata. Dalla burocrazia, dalla standardizzazione, dalla paura di sbagliare. Invece di accendere domande, l’istruzione contemporanea si limita a somministrare risposte. Ma una risposta priva di domanda non è conoscenza: è rumore. Un rumore che assorda la mente e spegne lo spirito. E nel lungo periodo, questa abitudine ad accettare passivamente ciò che ci viene detto si trasforma in una vera e propria paralisi cognitiva. Si smette di interrogare il mondo. Si smette di cercare.
In classe si lavora spesso per obiettivi minimi, per prove standard, per moduli didattici chiusi. Tutto è già stabilito. Tutto è già deciso. L’imprevisto non è contemplato. Ma è proprio nell’imprevisto che nasce la meraviglia. E senza meraviglia, imparare diventa una fatica sterile.
Il piacere del sapere ha lasciato il posto all’ansia da performance
Imparare è diventato noioso perché non ci si sente più liberi di esplorare. Ogni attività formativa è monitorata, valutata, classificata. Ogni errore ha un prezzo. Ogni deviazione un voto in meno. E così, si rinuncia a pensare. Si rinuncia a rischiare. Si segue la traccia, si memorizza, si ripete. Ma l’apprendimento non è una catena di montaggio. È un processo caotico, intermittente, irrazionale. E proprio per questo, profondamente umano.
Secondo l’ultimo rapporto dell’OCSE, la percentuale di studenti che dichiara di sentirsi “stressata” o “sotto pressione” durante le attività scolastiche è aumentata in modo significativo nell’ultimo decennio. L’apprendimento si è trasformato in una corsa contro il tempo, dove l’obiettivo non è più capire, ma arrivare primi. Ma arrivare dove, esattamente? All’accettazione sociale? Alla stabilità economica? Alla gratificazione del voto?
In questo panorama, l’insegnamento diventa una trasmissione unidirezionale. L’insegnante è giudicato più per la sua aderenza al programma che per la sua capacità di ispirare. Lo studente, invece, impara a performare, non a comprendere. A sopravvivere all’esame, non a vivere il sapere. Così il sapere stesso si svuota, perde consistenza, diventa superficie.
Il sapere non è mai stato così accessibile, eppure è così lontano
Viviamo nell’era dell’informazione. Ogni dato, ogni contenuto, ogni spiegazione è a portata di clic. Eppure, mai come oggi si ha l’impressione che imparare sia faticoso, sterile, poco coinvolgente. Il problema non è la mancanza di risorse. Il problema è che il sistema formativo continua a trattare lo studente come un contenitore da riempire, e non come un protagonista attivo del proprio apprendimento.
L’apprendimento ha bisogno di senso. Di applicazione. Di contesto. Se manca il legame tra ciò che si impara e ciò che si vive, il sapere diventa astratto, opaco, distante. Come pretendere che un ragazzo si appassioni alla matematica se non gli si mostra mai dove, come e perché può servirgli davvero? Come apprezzare la filosofia se viene ridotta a un esercizio mnemonico?
Il paradosso è evidente: più contenuti accessibili, meno desiderio di approfondire. L’abbondanza ha generato saturazione. E la saturazione ha anestetizzato la mente. Invece di selezionare, di scegliere, ci si perde in un flusso costante, privo di direzione. L’apprendimento, per tornare efficace, ha bisogno di cura. Di lentezza. Di intenzione.
Abbiamo bisogno di riformulare il significato di “imparare”
Imparare non dovrebbe essere sinonimo di passività. Non è un atto meccanico, ma una relazione. Tra soggetto e oggetto. Tra chi apprende e ciò che viene appreso. Quando questo legame è vivo, lo studio diventa stimolo. Quando è assente, si trasforma in obbligo. Serve quindi una rivoluzione del senso. Non solo dei metodi.
Le tecnologie digitali possono aiutare. Ma da sole non bastano. Non è una questione di strumenti, ma di visione. Bisogna restituire all’apprendimento la sua dimensione esistenziale. Bisogna permettere agli studenti di porre le proprie domande, di progettare percorsi personali, di sbagliare senza paura. Solo così si riaccende la scintilla.
La formazione dovrebbe diventare uno spazio di ricerca e sperimentazione, non di conformismo. Un ambiente in cui la complessità venga accolta, non ridotta. Dove si impara a pensare, non a ripetere. Dove l’obiettivo non è finire un programma, ma avviare un processo.
Imparare è un atto sovversivo
In un mondo che ci vuole efficienti, rapidi, produttivi, imparare davvero può diventare un atto di resistenza. Fermarsi a comprendere è già un gesto radicale. In un’epoca dominata dalla velocità e dalla superficialità, chi cerca profondità e significato sta già disobbedendo. Ecco perché imparare è diventato noioso: perché lo abbiamo svuotato del suo potere liberatorio.
Imparare è scomodo. Rompe equilibri. Crea dubbi. Spinge a cambiare. Per questo è così necessario. E per questo deve tornare a essere un atto vivo, incarnato, desiderato. Non un compito da svolgere. Ma un viaggio da intraprendere.
Nel momento in cui si smette di cercare, si smette anche di crescere. E ogni società che scoraggia la ricerca, scoraggia anche la trasformazione. Imparare, dunque, è molto più di un’attività scolastica: è una postura interiore, una forma di resistenza culturale, un modo di stare nel mondo. Riscoprirne il valore significa riconsegnare dignità alla mente umana. E ritrovare, forse, un senso profondo nella fatica del conoscere.